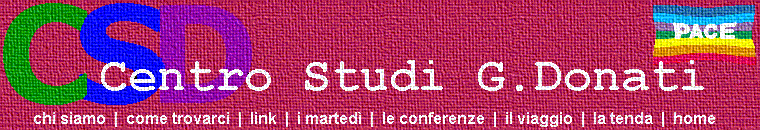
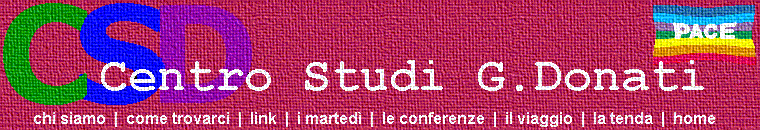
|
Hibrahim Farjallah ha 14 anni e una bicicletta. Era il premio in palio per chi avesse vinto il concorso di pittura “La Tartaruga e il Dugongo “, promosso dal Programma di Educazione Ambientale dell’Isola di Mafia, e lui ha vinto su 260 concorrenti. Sui pedali sarà molto meno faticoso raggiungere la scuola. Succede in un’incantevole isola della Tanzania, Mafia appunto, che si trova nell’Oceano Indiano circa 120 km a sud-est di Dar-es-Salaam. Qui ha sede un parco nazionale marino che è il cuore di un progetto pilota di protezione ambientale. Iniziativa del governo, sostenuta dal WWF, prevede infatti che le attività di sussistenza degli abitanti siano integrate nella conservazione dell’ecosistema, secondo un modello partecipativo di sviluppo sostenibile. Attraverso gli specifici comitati eletti dai villaggi, la popolazione viene continuamente consultata ed ha voce anche nei momenti decisionali. L’educazione e l’informazione sono fattori cruciali per la riuscita del progetto, che richiede la cooperazione di tutta la comunità: tra interviste e dibattiti, circa 200 pescatori e migliaia di scolari, con i loro insegnanti, sono stati coinvolti nel Programma di Educazione Ambientale. Il Mafia Island Marine Park copre una superficie totale di 822 kmq e entro i suoi confini vivono circa 18000 persone, più di un terzo della popolazione totale, raccolte in 11 villaggi. Il 50% di essi vive delle risorse marine, mentre un 10-15% trova sostentamento nella foresta di Mlole, unico esempio di foresta primaria costiera. Comprende la parte meridionale dell’isola e un arcipelago di numerose isole ed isolotti, in parte di fronte al delta del Rufiji.. Le sue acque ospitano, tra banchi di corallo e praterie sottomarine ricche di vita, quasi 400 diverse specie di pesci, 48 generi di coralli, 7 specie di mangrovie in una varietà di ecosistemi, anche terrestri, caratterizzati da un’alta bio-diversità. Sull’isola vivono130 specie di uccelli, aquile comprese. Solo qui e alle isole Comore si trova inoltre una rara specie di pipistrello. Istituito nel 1995, il Parco ha prodotto importanti risultati, come la cessazione della pesca con la dinamite e un certo cambiamento di mentalità. Chi prima cacciava le tartarughe ora ne protegge, remunerato, i nidi. Inoltre nel 1999, dopo 20 anni, sono ricominciati gli avvistamenti del dugongo, un mammifero simile alla foca dato per estinto in queste zone. La sfida attuale è diminuire la pressione della pesca, praticata con metodi non sostenibili, incoraggiando gli abitanti, attraverso microfinanziamenti, a intraprendere attività alternative, come la coltivazione delle alghe, l’allevamento dei pesci-gatto, l’apicoltura, la coltivazione di ortaggi. Tra le donne, tenute espressamente in conto dal progetto, si promuove la coltivazione dei funghi e l’artigianato. Si cerca così di comporre il conflitto che, in paesi poveri come la Tanzania, oppone le esigenze di protezione del patrimonio naturale al suo sfruttamento, per pura sussistenza, da parte della popolazione.
Il turismo, già presente in alcuni costosi lodge dal limitato numero di posti-letto, viene considerato una risorsa importante. Ma una risorsa che gli isolani hanno scelto di non far crescere troppo, ben consapevoli dei danni che può provocare, quando non controllata, sia all’ambiente fisico che sociale, come è successo sulla costa keniota (e in parte a Zanzibar). Per sua fortuna Mafia non è adatta al turismo di massa, perché gran parte delle sue coste è coperta dalle mangrovie e i collegamenti sono difficili. “C’è spazio soltanto per altri due o tre piccoli hotel, ” spiega il sovrintendente del Parco, Sylvester Kazimoto, “ perché la disponibilità di acqua dolce è limitata. Inoltre uno sviluppo eccessivo del turismo porterebbe a modificare i costumi della gente e noi non vogliamo che questo accada”. Nel Piano di Gestione si parla proprio degli effetti negativi che può avere la presenza massiccia di un turismo ricco, citando il problema dei beachboys in Kenya. Si parla di “erosione culturale”. E del pericolo che, come in altre situazioni simili, “le giovani generazioni possano adottare culture straniere a spese della propria”, in un vuoto che potrebbe portare all’uso di droghe, alla prostituzione e alla criminalità. Si vorrebbe promuovere piuttosto un ecoturismo sostenibile, interessato alla natura, alla cultura locale, alla visita dei siti storici (a Juani ci sono i resti di alcune moschee del XVI – XVII secolo). La specificità storico-culturale è un altro patrimonio di diversità da custodire. Le prime notizie storiche di Mafia (nome forse dall’arabo morfiyeh, gruppo) sono in relazione agli Shirazi, che dominarono la costa dell’Africa Orientale tra l’XI e il XIII secolo. Originari di Shiraz, in Persia, ne fecero una importante stazione commerciale, rendendola partecipe della ricca e raffinata cultura Swahili. A quell’epoca risale il sito di Ras Kisimani (XII secolo). Tracce degli Shirazi risulterebbero nella genealogie di alcune famiglie, tanto che una studiosa inglese vi sta compiendo ricerche, confrontando i dati, compresi i tratti somatici, con quelli di famiglie dell’attuale Iran, l’antica Persia. Nel 1498 giunsero i Portoghesi, quindi l’isola passò defintivamente sotto il controllo degli Arabi di Oman, installatisi a Zanzibar. La popolazione è composta principalmente dai discendenti degli ex-schiavi utilizzati nelle piantagioni di cocco e di anacardio, con numerosi apporti non solo dalla Tanzania continentale, ma anche dalle Seychelles, dalle Comore e dall’India. C’è una significativa comunità cristiana ma la gran parte degli abitanti è di religione musulmana.Un Islam aperto e tollerante, tanto che, secondo quanto afferma l’incaricata governativa per lo Sviluppo, gli uomini non ostacolano il suo lavoro di promozione della donna, che sta producendo importanti risultati. La convivenza tra religioni qui non è un problema, come testimonia la serie di contatti tra le diverse comunità che ha portato alla ristrutturazione dell’ospedale governativo, il cui finanziamento è arrivato per la maggior parte dall’Italia (sia da privati cittadini sia da associazioni).
Il porto di Kilindoni
Con manovre che si ripetono da secoli, i dhow dalla grande vela latina rientrano nel porto di Kilindoni prima del tramonto. Più tardi, in uno spiazzo dove qualcuno ha messo un televisore, come in un cinema all’aperto, numerose persone guardano attente il tubo catodico. Trasmette “Beautiful”. Forse seguirà la pubblicità, di modello occidentale, individualista e consumistica. Qualche perplessità sorge. Per superare la contraddizione basta sfogliare il bel calendario che riproduce le pitture di Ibrahim e degli altri bambini di Mafia, piene di candore ma anche di energia nel rappresentare la bellezza dell’ambiente e la sua difesa.
Massimo Lambertini Nigrizia (Febbraio 2003) |
Centro Studi "G.Donati" - Bologna |